 |
 |
 |
|
IL COLLOCAMENTO DEL MINORE DA 0 A 3 ANNI dott. Ezio Ciancibello Nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli riconoscendo a questi ultimi il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e di ricevere da loro cura, educazione ed istruzione. La legge cercava di riequilibrare una situazione in cui l'88 per cento degli affidamenti avevano carattere esclusivo, con la conseguenza di attenuare se non addirittura compromettere ogni significativo rapporto dei figli con il genitore non affidatario. Nei primi quattro anni in cui questa legge è entrata in vigore, risulta però una diffusa sostanziale inapplicazione da parte dei diversi tribunali della Repubblica, dovuta principalmente alla difficoltà, da parte dei giudici, a distaccarsi da precedenti prassi consolidate. Molti tribunali continuano infatti a sostenere che l'affidamento condiviso può essere concesso solo in un numero limitatissimo di casi, e debba invece essere negato laddove vi sia conflittualità fra i genitori, soprattutto in presenza di minori in tenera età. Anche la distanza tra le abitazioni dei due genitori può diventare una ragione per non concedere l’affido condiviso. La legge n. 54 del 2006 pone invece dei limiti precisi proprio all'affidamento esclusivo, consentendolo solo nelle situazioni in cui un genitore (quello da escludere dall'affidamento) costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli. Infine alcune sentenze introducono il concetto di collocazione prevalente dei figli in favore del genitore affidatario, influendo così in modo significativo su uno dei contenuti qualificanti della legge, quale la presenza equilibrata del minore presso i genitori.
Di tale incongruenza è stato investito il governo che ha risposto tramite la Sottosegretaria Alberta Casellati. (interrogazione a risposta in commissione n. 5-04232 del dep. Bernardini)
Dall'esame di tali dati emerge una netta inversione di tendenza a favore dell’affidamento condiviso a partire dal 2006, fino a giungere nel 2008 alla rilevante percentuale del 78,8% di separazioni, e del 62,1% di divorzi con figli in affido condiviso. L'esame dei dati non conferma, quindi, quanto indicato nell'interrogazione con riferimento ad una "sostanziale inapplicazione" della nuova forma di affidamento da parte dei Tribunali italiani, che sarebbe concesso in un numero "limitatissimo di casi". Non si hanno, invece, rilevazioni statistiche, sui casi di "svuotamento" dell'affidamento condiviso, consistenti nell'introdurre il concetto di "collocazione" dei figli presso uno dei due genitori. L'eventuale individuazione di un genitore "collocatario", presso il quale il figlio minore abbia la propria dimora prevalente, non influisce, tuttavia, sulla distribuzione della responsabilità genitoriale che, nel caso di affidamento condiviso, continua ad essere equamente distribuita tra i genitori. La previsione di una dimora abituale può scaturire o dallo stesso accordo tra i coniugi (tale modalità di regolamentazione è, infatti, molto spesso presente nelle separazioni consensuali e nelle richieste di divorzio congiunto) o da provvedimenti adottati dal Tribunale che possono rendersi necessari per due ordini di ragioni. La prima ragione è da ravvisare nella necessità che il minore, soprattutto se in tenera età, abbia un preciso punto di riferimento logistico, elemento necessario per un corretto sviluppo psico-fisico. Prevedere, infatti, una pari presenza del figlio nelle abitazioni di entrambi i genitori, implicherebbe un continuo trasferimento del minore, con effetti disorientanti per la sua crescita. Nella legge n.54/2006 che disciplina l'affidamento condiviso, sono state introdotte disposizioni in materia di assegnazione della casa coniugale. Tali disposizioni si sarebbero dovute ritenere superflue qualora il legislatore non avesse riconosciuto il diritto del minore a conservare un luogo di residenza, quanto meno "prevalente". La seconda ragione che può giustificare il ricorso al "collocamento" prevalente del minore presso uno dei due genitori è da ravvisarsi, nel caso di separazioni o divorzi molto conflittuali, nell’esigenza di attenuare i conflitti attraverso una puntuale disciplina dei rapporti. Se, infatti, come sostenuto dagli interroganti e come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. N.16593 del 18.6.2008), la conflittualità tra i genitori non può giustificare il ricorso all'affidamento esclusivo, è pur vero che può rendere estremamente difficoltosa la gestione quotidiana dell'affidamento condiviso. Tuttavia, quanto alla residenza del figlio, in mancanza di accordo dei genitori, decide il giudice stabilendo, senza modificare l'affidamento condiviso, le modalità di residenza. Posto, dunque, che la previsione nel provvedimento giudiziale di una residenza prevalente del minore non riduce, nè diminuisce i diritti del genitore "non collocatario", tengo a sottolineare che le eventuali distorsioni nella corretta applicazione delle norme da parte delle Corti di merito possono essere censurate ricorrendo, nel caso di abusi commessi dal genitore "collocatario", al procedimento disciplinato dall'art. 709 ter del c.p.c.. Ciò detto, non si può non convenire sulla situazione di forte disagio conseguente al collocamento prevalente presso uno dei genitori e non si può del pari, non impegnarsi in approfondite riflessioni concettuali. Il mio contributo, come CTU presso il Tribunale di Venezia e di Pordenone parte proprio da queste ultime frasi della sottosegretaria A. Casellati e dalla richiesta, sempre più frequente da parte di padri separati che chiedono un tempo paritetico a quello della madre, da trascorrere insieme ai propri figli. Di solito il giudice valuta autonomamente le capacità genitoriali e sulla base di quanto i genitori riferiscono decide se debba essere condiviso o esclusivo, stabilendo anche il tempo che i figli devono trascorrere con loro. Nel caso emergessero particolari problemi di natura psicologica, nomina un CTU che ha il compito di esaminare i genitori ed il minore ed il rapporto che sono in grado di instaurare, in modo da fornire al giudice maggiori elementi per decidere in merito all’affido. Siamo quindi di fronte a separazioni giudiziali che tuttavia, come le consensuali, hanno l’obiettivo principale di tutelare il minore affinché possa mantenere un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Vorrei allora prendere in considerazione, nel caso specifico, una coppia di genitori con una bambina di 1 anno e mezzo, ma i generale tutte quelle situazioni di affido con minori la cui età si colloca dai 0 ai 3 anni, il cui padre chiede di poter trascorrere con la figlia un tempo paritetico a quello della madre. Questa riflessione è circoscritta però solo a quei genitori a cui vengono riconosciute adeguate capacità genitoriali, in modo da evitare casi problematici che richiederebbero altre e più dettagliate argomentazioni. L’Ordine degli Psicologi del Veneto ha istituito un gruppo di lavoro, di cui faccio parte, che da un anno circa si è confrontato sull’approfondimento e la ricerca dei criteri più idonei per definire la capacità genitoriali, ed abbiamo a questo proposito individuato le seguenti “linea guida” di cui fornisco una anticipazione, visto che debbono ancora essere pubblicate sul bollettino dell’Ordine. 4.2 La valutazione psicologica della genitorialità All’interno di questa nuova cornice normativa, rivolta a soddisfare il diritto del minore alla co-genitorialità e il diritto/dovere dei genitori ad assolvere i loro compiti, il Consulente Tecnico deve valutare le capacità genitoriali potenziali e concrete rispetto agli specifici bisogni della prole.
L’accertamento delle risorse genitoriali dovrà tenere presente - la capacità di accudimento e cura dei figli; - la qualità delle relazioni di attaccamento; - l’attenzione ai bisogni reali dei figli; - le capacità empatiche, riflessive e di ascolto di entrambi i genitori, in funzione di un adeguato sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico del minore; - il riconoscimento del ruolo dell’altro genitore mantenendo la stabilità e la continuità dei legami. Verranno considerati, altresì, eventuali comportamenti strumentali, rivolti a contrastare o condizionare l’esercizio della funzione genitoriale, da parte dell’altro genitore; - la capacità di cooperazione, vale a dire la disponibilità di entrambi i genitori a condividere le decisioni di maggiore interesse del minore – mantenimento, salute, istruzione ed educazione – nonché la fiducia nella gestione delle questioni che attengono all’ordinaria amministrazione; - l’approfondimento del profilo personologico, qualora se ne ravvisi la necessità, per la rilevazione di elementi di psicopatologia che possono interferire con la capacità genitoriale.
I genitori valutati idonei nelle loro capacità genitoriali sono in grado di occuparsi dei propri figli, anche se chiaramente non nello stesso identico modo, inoltre il padre, prima della separazione, nella fascia d’età compresa tra 0-3 anni, di solito partecipa relativamente all’accudimento del minore, anche se è più presente nella sua vita rispetto a quanto riusciva a fare il proprio padre. C’è stato in effetti negli ultimi venti anni, un mutamento nel ruolo paterno, che recenti ricerche in campo psicologico hanno evidenziato. I padri di oggi sono più capaci di riflettere e di mettere in discussione i propri comportamenti e di ascoltare ed empatizzare maggiormente con i propri figli. Tuttavia la nuova paternità non modifica la priorità che i padri attribuiscono al lavoro. Sanno di non poter conciliare i tempi relativi alle “questioni domestiche” con quelli lavorativi, e spesso privilegiano i secondi a scapito del tempo da trascorrere in compagnia dei figli. Contraddizione invece con cui la madre già da molti anni ha dovuto confrontarsi trovando comunque il modo, anche a prezzo di notevoli sacrifici, di conciliare o rinunciare alla sua realizzazione lavorativa, per dedicarsi all’accudimento dei figli. 5 Si possono quindi equiparare le competenze genitoriali, laddove risultino adeguate in entrambi i genitori, ritenendo che siano, tutto sommato sovrapponibili? Certo si potrà obiettare, uno può essere meno sensibile o emotivo, di solito il padre, ma questo non impedisce certamente che sappia mettersi all’ascolto delle esigenze del minore sapendole anche riconoscere e soddisfare. In realtà non si può “dimenticare” che il padre inizia a conoscere il proprio figlio, e ad entrare in relazione con lui, solo dopo 9 mesi di gestazione nell’utero della madre. Questo periodo di tempo introduce una variabile nel rapporto minore/genitori, che ha una rilevanza psicologica. La psicologia prenatale grazie anche ad una tecnologia biomedica sempre più perfezionata e ad una metodologia della ricerca sempre più precisa, ha consentito di indagare il mondo intra-uterino a Il legame di attaccamento prenatale Winnicott (1958), mise per la prima volta in evidenza come la relazione genitori-bambino prenda origini nelle fasi precedenti alla nascita, nell’impegno affettivo che la madre sviluppa verso il bambino atteso, introducendo il concetto di preoccupazione materna primaria basato sulle osservazioni delle prime fantasie che esprimevano i genitori in merito al bambino che si stava sviluppando nel grembo della madre. Queste rappresentazioni cognitive e relative fantasie sono state elaborate in seguito dalla Cranley (1981) che ha introdotto il termine attaccamento prenatale proprio per descrivere le caratteristiche del legame che i genitori sviluppano durante le fasi della gravidanza del il bambino. In uno dei primi studi in questo campo Lumley (1972) individuò due aspetti: il primo che con il progredire della gravidanza il feto veniva pensato progressivamente sempre più come persona, il secondo che le madri stabilivano precocemente un legame di attaccamento con il feto. Le ricerche che riguardano le fantasie della madre in merito al bambino che porta in grembo, mostrano anche che sono predittive della relazione madre-bambino dopo la nascita. Vi sono infatti sempre maggiori evidenze di come la qualità dell’attaccamento prenatale, in particolare l’attaccamento materno-fetale, si mantenga nella successiva relazione con il neonato, ed è opinione condivisa tra gli studiosi che una buona relazione madre-neonato costituisca una condizione di base per la prevenzione dei disagi dello sviluppo psicofisico del bambino. Pochi sono invece i lavori che hanno indagato le rappresentazioni paterne e, ancora meno, quelli relativi alle rappresentazioni dei due genitori insieme. Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attaccamento paterno-fetale in un recente studio italiano (Righetti et al., 2005) è emerso che, a differenza dall’attaccamento materno-fetale che si incrementa con il progredire della gravidanza, nella popolazione maschile l’attaccamento al feto si sviluppa nel primo trimestre e poi si mantiene ad un livello costante fino alla fine della gravidanza. In una lettura psicoanalitica relazionale della salute mentale dell’individuo, si considera di grande importanza il ruolo dei fattori di sostegno affettivo, emotivo da parte dei familiari della gestante, in particolare del padre, sulle possibilità di sviluppo di un adeguato e sano attaccamento materno-fetale. Il padre si colloca tra il figlio e la madre garantendo sicurezza e protezione alla diade, attraverso il contenimento affettivo ed emotivo. La funzione paterna è una risorsa per la diade. Tali considerazioni erano già presenti nei lavori e nelle opere dello psicoanalista F. Fornari (1984) che individuava non solo il profondo legame che si instaura tra la madre ed il bambino che porta in grembo, ma anche le paure e le ansie che sottendono questo legame e che possono essere “bonificate” grazie alla presenza del padre, al suo aiuto e alla sua comprensione. Alla donna in gravidanza viene spontaneo affidare all’uomo il compito di contenerla e di proteggerla, anche se in realtà quest’ultimo si pone spesso in contrapposizione con il feto perché si sente escluso da un rapporto di cui solo la madre ha l’esclusiva. Il bisogno di essere protetta e rassicurata diviene ancora più pressante durante il parto che minaccia la simbiosi tra madre e bambino e che getta le basi di quella che Fornari ha definito “paranoia primaria” che esprime la paura di quello che potrà accadere a se stessa o al nascituro, durante il travaglio, e mette di fronte la madre alla prima separazione rispetto al bambino che prima cresceva e si sviluppava nel suo grembo. Una ricerca svolta da un allievo di Fornari, lo psichiatra e psicoterapeuta G. Charmet (1987), su un nutrito gruppo di madri che avevano appena partorito, ha messo in evidenza una serie di fantasie sul modo in cui si rappresentavano la figura del padre. Da una parte c’erano madri che si appoggiavano a lui cercando sicurezza e sostegno dall’altra madri che ritenevano la gravidanza come un fatto esclusivo della donna, da cui l’uomo era completamente esautorato. Fantasie quindi di onnipotenza, di partenogenesi che “..si spinge fino ad assorbire il concepimento stesso come un progetto di accoppiamento della donna con se stessa..” Ora queste considerazioni psicologiche ed evidenze scientifiche permettono di concludere che: - la madre fissa un legame di attaccamento prenatale con il figlio che se da una parte garantisce la sua sopravvivenza (spinta evolutiva) dall’altra può rivelarsi un attaccamento regressivo (spinta involutiva) che la conduce, sulla base di fantasie di onnipotenza, a ritenere che sia l’unica che può accudirlo e proteggerlo. - Il padre ha il compito di sostenere ed aiutare la madre affinché non venga “assorbita” dal rapporto con il figlio (rapporto simbiotico). - Il neonato ha una sua autonomia, seppure parziale e limitata, rispetto alla madre che lo contiene nel suo grembo.
La nascita del bambino permetterà di verificare, a seconda di come si svilupperà il rapporto con la madre, se e come questo si modificherà e se e come il padre saprà dare il necessario sostegno e supporto e come il bambino si relazionerà con loro. Tuttavia dalla nascita in poi il padre non si limiterà più a svolgere solo funzioni di supporto per la madre dal momento che anche lui avrà modo di interagire direttamente con il bambino, cosa che non poteva fare durante la fase di gestazione. Nella storia della psicologia evolutiva ed anche della psicopatologia clinica, l’unità di osservazione è sempre stata però quella di madre/bambino. Una relazione quindi di tipo diadico. Si pensi al paradigma dell’attaccamento di Bowlby (1988), a quello della Bretherthon (1994) per cui il legame che il bambino instaura con la madre “determina” anche la qualità del legame con il padre. In questi studi l’idea di fondo è quella che il bambino tende a sintonizzarsi naturalmente con un unico caregiver (generalmente la madre) prima di passare a instaurare relazioni più complesse con altri (il padre). Alcuni autori (Tambelli e coll., 1995; Camaioni, 1996; Howes, 1999) affermano che il presupposto teorico secondo cui il neonato ha inizialmente una capacità di regolare solo le relazioni diadiche per poi accedere, in un secondo momento, a quelle triadiche e alle triangolazioni dipende da un eccessivo riferimento ad un costrutto “madricentrico”, che finora ha influenzato le procedure di ricerca. A questa tendenza si contrappone il gruppo di Losanna, coordinato da Fivaz-Depeursinge e Corboz-Warnery (1993), che parte dal presupposto che per studiare la famiglia non è possibile soffermarsi solo sulle sue componenti diadiche, in quanto bisogna anche attivare una osservazione triadica (madre/figlio/padre). Nasce quindi il concetto di “triangolo primario”, il Lausanne Trilogue Play (LTP) ove la famiglia viene considerata come un insieme unico, un’unica unità in cui le modalità di partecipazione dei diversi attori possono essere fatte variare sistematicamente. In questo modo i professionisti che lavorano nell’ambito della genitorialità possono avere non solo una visione della relazione diadica (madre-bambino, padre-bambino, madre-padre) ma anche di quella triadica, con la possibilità di valutare quanto il senso di cooperazione e di coinvolgimento tra i genitori influenzi e favorisca lo sviluppo del bambino. In queste ultimi anni poi c’è stata una integrazione tra Infant Research , psicoanalisi infantile, interventi clinico-sperimentali derivati dalle teorie dell’attaccamento e neuroscienze, cha hanno permesso di evidenziare, attraverso evidenze sperimentali come la maturazione neuropsichica dipenda dal tipo di relazione madre/feto/neonato/bambino e poi madre-padre/bambino. Da ulteriori ricerche risulta inoltre che i padri, quando si ritrovano nel ruolo di caregiver primario, mostrano di avere le competenze genitoriali necessarie (Palmeri, 1989) visto anche le competenze precoci del neonato a stabilire relazioni sociali differenziate. Si è così sviluppata una clinica rivolta non tanto a curare il singolo, quanto a modificare le relazioni – madre/neonato/bimbo e madre/padre/bimbo – matrici della costruzione della mente e del cervello del futuro individuo. Il paziente non è mai il singolo, ma le relazioni che si stabiliscono all’interno del triangolo madre-padre/bambino. Al padre va quindi riconosciuto, quando lo esercita, un ruolo che va ben oltre il classico stereotipo che lo vede responsabile del sostegno economico della famiglia, mentre le madri non possono più essere considerate le maggiori responsabili per lo sviluppo psico-emotivo del bambino. Tuttavia al di là della gestazione vi è un'altra fase che permette alla madre di avere un rapporto con il proprio figlio che può essere considerato ancora esclusivo. Quello relativo all’allattamento. L’allattamento è una situazione unica che tende a rinsaldare ancora di più il legame madre/neonato. Il primo contatto con il seno, come prescrivono i pediatri, dovrebbe avvenire entro un’ora dalla nascita, lasciando la mamma e il bambino, insieme al papà se presente, liberi di interagire spontaneamente, senza interferenze esterne. Il bambino ha vissuto per nove mesi nell'utero materno, una volta nato ha la necessità di continuare a mantenere un contatto continuo con la madre. Infatti fin dai primi minuti della sua nascita viene accolto, riscaldato, accudito, nutrito e protetto dalla madre. Madre e figlio instaurano un contatto “pelle-a-pelle” per rinnovare un rapporto che ora, a differenza di prima, passa attraverso il contatto fisico dei due corpi che iniziano ad esplorarsi e ad conoscersi in modo più diretto. Si tratta di un rapporto reciproco di incontro e scambio che potrà proseguire, in modo esclusivo, per almeno 6 mesi. Secondo quanto riportato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall'UNICEF, e dell’Unione Europea, recepite anche dal nostro ministero della Salute, tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati al seno per i primi sei mesi di vita (26 settimane). Il mancato allattamento al seno, e in particolare il mancato allattamento esclusivo al seno durante i primi sei mesi di vita, sono importanti fattori di rischio e possono causare una maggiore mortalità e propensione ad ammalarsi dei neonati e dei bambini. Viene inoltre suggerito di proseguire l'allattamento fino ai due anni e oltre, se il bambino si dimostra interessato e la mamma lo desidera. Il padre in questa fase ha ancora il compito di sostenere la madre, che si dedica prevalentemente al bambino, in molti modi diversi, senza per questo rinunciare a stabilire un rapporto con lui. Si è potuto così osservare che la sua benevola e partecipata presenza può favorire un migliore allattamento, rafforzare il rapporto madre-padre e stabilire un contatto significativo con il bambino. Sebbene alcuni padri si sentano esclusi dalla possibilità di nutrire il bambino, altri invece ritengono l'allattamento al seno un'ottima esperienza di legame familiare che li portano a prendere su di sé determinati doveri familiari e di lavoro in modo che non creino ostacolo alla madre che può così dedicarsi con maggiore disponibilità al bambino. Queste conoscenze conducono ad una serie di ulteriori considerazioni psicologiche basate su evidenze scientifiche. - La madre è sollecitata fisiologicamente ed anche psicologicamente a fissare un legame di dipendenza con il proprio figlio che è molto marcato. Non a caso si parla di rapporto simbiotico, che è fondamentale per il suo sano sviluppo psicofisico. Tale legame inizia durante il periodo di gestazione e viene rinsaldato dopo la nascita con l’allattamento. La madre è pertanto costretta a confrontarsi con due potenti forze emotive che deve saper bilanciare dentro di sé e che sono fondamentali per lo sviluppo psicofisico del minore. La prima spinge a trattenerlo per sé, ritenendo che solo attraverso il suo contatto e la sua attenzione possa crescere in modo sano. La seconda spinge invece verso la separazione che porta il minore ad emanciparsi da lei in modo che possa iniziare ed individuarsi come persona. La capacità di saper elaborare queste potenti spinte contrapposte pone la madre nelle condizioni di assumere su di sé un compito evolutivo che condizionerà non solo la possibilità del minore di individuarsi psicologicamente, ma anche il tipo di rapporto che potrà avere con il padre, che chiaramente dipenderà anche dalle sue capacità di sapersi occupare delle esigenze del minore. - Il padre mantiene un rapporto di sostegno e supporto a favore della madre che favorisce il contatto che potrà sviluppare con il minore oltre a rassicurala rispetto alla possibilità che quest’ultimo possa avvicinarsi ad un padre che percepisce come sensibile ed attento e quindi in grado di occuparsi del “suo” bambino. - Il neonato è in grado di stabilire e sviluppare una relazione con entrambi i genitori, seppure in tempi e modi diversi.
Arrivati a questo punto possiamo dare una risposta parziale in merito alla richiesta di un padre di poter gestire il proprio figlio (da 0 a 3 anni) con tempi paritetici a quelli materni. Se la madre allatta il minore tale richiesta a mio avviso non può essere sostenuta e proposta al giudice per una serie di evidenze “logiche” che difficilmente possono essere confutate. Infatti è impensabile, se stanno a cuore gli interessi preminenti del minore, come sancisce la legge sulla separazione, che durante i tempi di permanenza presso la madre venga allattato al seno e quando è con il padre venga nutrito con il latte artificiale attraverso il biberon. Questo però non impedisce che il padre possa frequentare e tenere con sé il bambino ma sempre rispettando i suoi tempi per l’allattamento. Il problema che si pone semmai è quello relativo al fatto che possa essere allattato fino all’età di 2 anni ed oltre come prevede l’OMS e l’UNICEF. E’ sano da un punto di vista psicologico che un minore venga all’allattato quando ha già 2 anni? Il problema in termini concreti non è frequente poiché oggi gran parte delle madri hanno un lavoro che non le consentono di assentarsi così a lungo, ma anche se lo fosse non esistono ricerche scientifiche che stabiliscono che i bambini allattati fino a 2 o 3 anni sviluppano maggiori capacità cognitive o fisiche o socializzano meglio di quanto hanno terminato l’allattamento a 6 mesi, o non hanno avuto modo di farlo. Le stesse madri hanno opinioni diverse al riguardo. C’è chi dice che i bambini vanno svezzati specie quando iniziano a spuntare i denti e chi ritiene invece che sia importante continuare a farlo fino a quando il bambino lo desidera. Si può e si deve allora fare riferimento a quanto l’OMS e l’UNICEF e la stessa Unione Europea ha stabilito e cioè che i bambini “dovrebbero” essere esclusivamente allattati al seno per i primi sei mesi di vita. (26 settimane) Laddove questo non fosse possibile, o perché la madre non vuole farlo o per una scarsa produzione di latte o per l’esistenza di una controindicazione ad allattare al seno, ed il minore dovesse essere allattato con il biberon, è pensabile che anche il padre possa farsene carico, chiedendo un periodo paritetico a quello della madre? Il neonato deve imparare ad integrare forti stimoli biologici che passano dal sonno alla veglia, dalla fame alla sazietà, dal freddo al caldo, dal buio alla luce, dal dolore al benessere e solo quando questi vengono padroneggiati con maggiore abilità può iniziare a partecipare agli eventi sociali che si ripetono intorno a lui con regolarità. Va da se che tali stimoli sono accompagnati da vissuti emotivi ed interazioni psicologiche con i genitori che contribuiscono a formare e sviluppare la sua personalità. Il bambino a questo punto è svezzato e di solito accade dal 6° mese di vita compiuto quando è ormai sicuramente pronto da ogni punto di vista: psichico, motorio, digestivo. Il problema che allora si pone è a mio avviso, simile rispetto a quello che caratterizzava la fase dell’allattamento: il neonato non può integrare tutti questi stimoli durante la fase dello svezzamento in due case diverse, con due genitori che hanno abitudini, stili di comportamento e tempi diversi. Questo finirebbe per creare confusione nella sua mente e nelle sue abitudini e ne uscirebbe disorientato. Tuttavia il dr. Vezzetti evidenzia l’assenza di ogni ricerca scientifica che in campo internazionale possa suffragare l’ipotesi che l’affido alternato sia dannoso per il minore e nella sua audizione davanti al Senato sul DDL 957 dice:”.. In particolare il rapporto Raschetti, presentato al parlamento transalpino e costituente il più ampio studio psicologico mai eseguito a livello mondiale, sul tema, ha osservato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti (dovendosi solo regolare i tempi di alternanza) e che i bambini curati da un solo genitore, inoltre, sono meno socievoli e hanno minor sviluppo cognitivo….Purtroppo in Italia, dove manca l'esperienza empirica dell'alternato, può ancora capitare di leggere che esso "può compromettere la crescita e provocare traumi in grado di evolvere verso patologie dissociative" (sic). Non di rado i tribunali minorili, così come quelli ordinari, rifiutano il pernottamento dei figli al di sotto dei 3 anni presso il padre, o addirittura richiedono una consulenza tecnica di ufficio per verificare, con atto di chiara discriminazione per sesso, le “attitudini e capacità” del genitore maschio alla cura filiale. L’affido alternato viene spesso definito destabilizzante e nocivo. Ma su che base? Su nessuna che non sia quella dell’epidermicità, del pregiudizio, del luogo comune……Nei motori di ricerca medico scientifica internazionali che abbiamo a lungo setacciato non esiste infatti un solo lavoro che suffraghi con validazione statistica questa bizzarra teoria….Rimanendo in Italia, anche il Prof. Canziani (tre volte Presidente degli neuropsichiatri infantili italiani), trova nel complesso positiva l’esperienza dell’alternato (cfr. “I figli dei divorzi difficili”, Sellerio editore). Le ricerche empiriche, basate sull’osservazione diretta, portano ad ipotizzare che il bambino, per lo meno nel primo anno di vita, ha bisogno di un punto di riferimento prevalente che gestisca con continuità e competenza i suoi bisogni e le sue attività quotidiane in modo che possa sentirsi accolto, rassicurato e confortato. Certo queste ricerche non hanno l’avvallo della comunità internazionale, come scrive il dr. Vezzetti, però che necessità c’è che un bambino da 0 ad 1 anno debba essere collocato con tempi paritetici nella casa di entrambi i genitori? Non esistono del resto ricerche scientifiche che stabiliscono che un minore da 0 ad 1 anno vede compromesso il suo sviluppo psico-fisico se non trascorre lo stesso tempo a casa dei genitori e non invece 3 o 4 giorni alla settimana a casa dell’uno invece che dell’altro. Se i genitori sono stati valutati adeguati nelle loro funzioni genitoriali ed entrambi richiedono di averlo anche durante la fase dello svezzamento è preferibile che tale compito venga svolto dalla madre dal momento che il rapporto che ha avuto con lui, durante la fase della gestazione, le ha permesso di fissare una attenzione ed una sensibilità nei suoi confronti che il padre non ha ancora avuto modo di sperimentare. Questo chiaramente non impedisce che il padre possa partecipare al suo sviluppo e crescita psicologica individuando dei tempi di permanenza congruenti a salvaguardare e tutelare il rapporto padre-figlio. Quando però il padre, come nel caso indicato a pag.3, con una bambina che ha superato l’anno, chiede di potersene occupare per un tempo equivalente a quello della madre, può essere esaudito nella sua richiesta o al contrario la minore deve essere collocata prevalentemente presso la madre? A mio avviso questo può dipendere solo dalle seguenti 3 variabili: I. La capacità dei genitori di occuparsi delle esigenze del minore; I genitori presi in esame nel nostro esempio, sono stati valutati idonei nelle loro funzioni genitoriali. Il padre in particolare ha dimostrato di essere stato capace di occuparsi adeguatamente sia delle necessità pratiche della minore, preparare le “pappe” completare l’assestamento veglia-sonno compreso anche il controllo sfinterico che è stato raggiunto pur non essendo sotto il controllo diretto della madre, che di quelle psicologiche, manifestando attenzione, sensibilità ed empatia. II. La capacità della madre di separarsi dal minore per affidarlo al padre; Ci sono state notevoli difficoltà che hanno avuto un risvolto molto pesante per la dignità del padre. La madre infatti era abituata, all’interno della propria famiglia di origine, a confrontarsi con ruoli genitoriali tradizionali. Il proprio padre provvedeva all’economia della famiglia e si limitava ad intervenire presso i figli solo per questioni prettamente educative, mentre la madre aveva il compito di prendersi cura delle loro necessità emotive. Questo modello familiare è entrato in crisi, quando la madre del nostro esempio, ha dovuto confrontarsi con le richieste del marito, che chiedeva di occuparsi della bambina appena nata con più continuità rispetto alle normali cure che di solito, nella sua famiglia, erano competenza esclusiva della madre. Tali richieste avevano suscitato nella madre dapprima un certo fastidio che si era poi trasformato in irritazione, dal momento che aveva sempre più spesso il “padre fra i piedi” per sfociare poi nel dubbio che il suo comportamento fosse troppo morboso, ed infine per allarmarsi quando il padre nel fare il bagnetto alla bambina aveva commentato: “..ma guarda che bella fighetta!..” Si era allora consultata con la propria madre ed entrambe avevano pensato che ci fosse qualcosa di strano nei suoi comportamenti ed avevano così deciso di denunciarlo ai carabinieri perché aveva delle “attenzioni sessuali” verso la minore. Tale accusa, che avrebbe potuto avere delle conseguenze assai gravi sul rapporto padre/figlia si rivelò, grazie al lavoro peritale, totalmente infondata e fu possibile grazie alla collaborazione fra CTU e CCTTPP farla rientrare. La capacità della madre di separarsi del proprio figlio è un passaggio molto critico e spesso è una delle cause principali della Sindrome di Alienazione Genitoriale.(Pas) III. La capacità della minore di separarsi dalla madre per iniziare a sviluppare un rapporto affettivo con il padre. La minore aveva manifestato una buona capacità di relazionarsi con entrambi i genitori senza mostrare difficoltà sia nel separarsi dalla madre, sia nell’avvicinarsi al padre e rimanere da sola con lui. Se le prime due variabili non evidenziano problemi significativi allora si può individuare il regime di visita più idoneo, che non potrà in questo caso essere condizionato nè dagli “spostamenti” che la minore deve fare tra le abitazioni dei genitori, né dal fatto che debba per forza avere un luogo prevalente ove abitare. La stabilità degli affetti e dei sentimenti è più importante della stabilità del domicilio e di eventuali spostamenti. Però ci possono essere delle situazioni, relative al III^ punto, che possono creare dei problemi in merito ai tempi di permanenza presso i genitori dal momento che il minore non sempre è grado di fissare un rapporto paritetico con loro e questo indipendentemente dall’influenza della madre e/o dall’inadeguatezza del padre. Che tipo di attaccamento ha sviluppato il minore con i genitori? Possiamo pensare che sia “identico” o che abbia delle “preferenze”? Che possa sentirsi più in sintonia, accudito, compreso con uno a differenza dell’altro? Penso che non occorra avere delle evidenze scientifiche per stabilire che l’attaccamento del minore nei confronti dei genitori non è identico. Pertanto se ci sono delle preferenze che manifesta per un genitore bisognerà ridurre il tempo di permanenza a casa dell’altro, in modo da dare il tempo al minore di 15 elaborare la separazione dal genitore al quale è più legato, senza per questo penalizzare l’altro genitore, che dovrà comunque mantenere una rapporto significativo con lui. Infine vi possono essere altre condizioni che impediscono che il minore possa trascorrere un tempo paritetico con i genitori, e queste sono relative ai loro tempi lavorativi ed alla distanza fra le rispettive abitazioni. Questo non impedisce di individuare ugualmente dei tempi di frequentazione con il genitore che ha impegni lavorativi più vincolanti che non potranno però essere compensati collocando ugualmente il minore presso i nonni o la baby sitter del genitore che è impegnato sul lavoro. Se uno dei genitori ha la possibilità di trascorrere più tempo con il minore, poiché i suoi tempi lavorativi lo consentano e giusto che venga preferito rispetto ad un figura terza (nonni-baby sitter) che sono delle risorse particolarmente importanti ed utili in determinate situazioni, ma non possono certo sostituirsi ai genitori. La mia riflessione si conclude qui ove ho cercato di evidenziare i 3 criteri che a mio avviso permettono di stabilire se l’affido debba essere consensuale o esclusivo e di individuare di conseguenza i tempi di permanenza del minore presso i genitori, che potrà corrispondere ad un tempo alternato nelle situazioni che meglio si prestano a soddisfare le sue esigenze o ad un tempo, tendenzialmente comparabile, ma non necessariamente paritetico, tra madre e padre, che garantisca comunque il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.
Dr. Ezio Ciancibello Psicologo – Psicoterapeuta, consulente CTU presso il Tribunale di Venezia - docente del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Criminologia Clinica (CR) – vicepresidente per il Veneto dell’ A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani). |



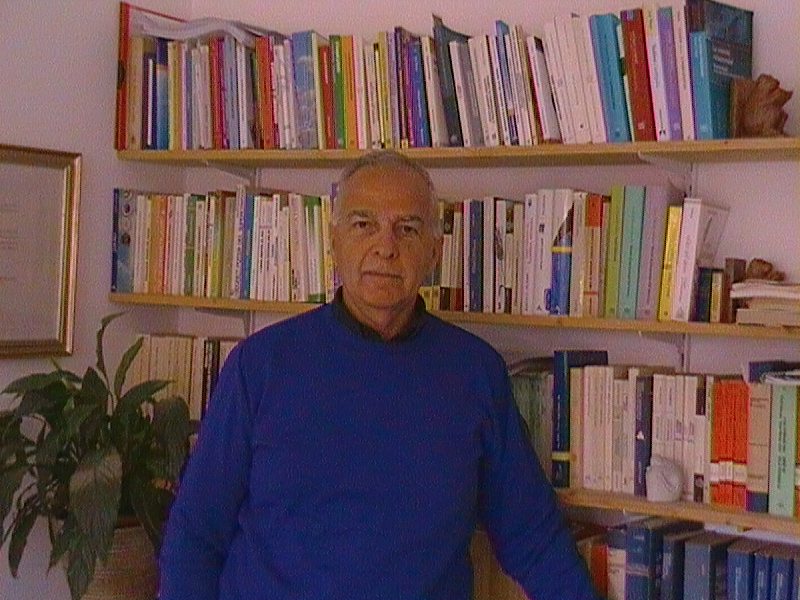 rrivando a concludere che vi è uno stretto legame tra madre e feto e che esso stabilisce delle relazioni assai complesse con l’ambiente intra- ed extrauterino. E’ infatti in grado di comunicare con la madre, e attraverso il suo grembo con il padre e con altre persone. E’ in grado di ascoltare, apprendere e memorizzare. Nei nove mesi della gestazione, il feto vive immerso in un mondo di stimoli multiformi che orientano le tappe del suo sviluppo neurofisiologico, grazie anche ad una serie di stimoli emotivi che influiscono sul suo sviluppo mentale. E’ risaputo, grazie a ricerche ed evidenze scientifiche condivise dalla comunità internazionale, che tra la madre ed il bambino viene a crearsi durante la gravidanza, uno stato di simbiosi che è all’origine di importanti interazioni che si possono riconoscere a diversi livelli. Alcuni studiosi ritengono che il feto assorba le emozioni materne e che i soggetti caratterizzati da una solida fiducia di base e da buona autostima abbiano potuto percepirsi fin dai primordi della vita psichica come individui desiderati e amati. Alla luce di questi ed altri svariati contributi scientifici, è quindi possibile dimostrare l'esistenza di un mondo psichico ed emotivo fetale e la presenza di un legame madre bambino prenatale.
rrivando a concludere che vi è uno stretto legame tra madre e feto e che esso stabilisce delle relazioni assai complesse con l’ambiente intra- ed extrauterino. E’ infatti in grado di comunicare con la madre, e attraverso il suo grembo con il padre e con altre persone. E’ in grado di ascoltare, apprendere e memorizzare. Nei nove mesi della gestazione, il feto vive immerso in un mondo di stimoli multiformi che orientano le tappe del suo sviluppo neurofisiologico, grazie anche ad una serie di stimoli emotivi che influiscono sul suo sviluppo mentale. E’ risaputo, grazie a ricerche ed evidenze scientifiche condivise dalla comunità internazionale, che tra la madre ed il bambino viene a crearsi durante la gravidanza, uno stato di simbiosi che è all’origine di importanti interazioni che si possono riconoscere a diversi livelli. Alcuni studiosi ritengono che il feto assorba le emozioni materne e che i soggetti caratterizzati da una solida fiducia di base e da buona autostima abbiano potuto percepirsi fin dai primordi della vita psichica come individui desiderati e amati. Alla luce di questi ed altri svariati contributi scientifici, è quindi possibile dimostrare l'esistenza di un mondo psichico ed emotivo fetale e la presenza di un legame madre bambino prenatale.